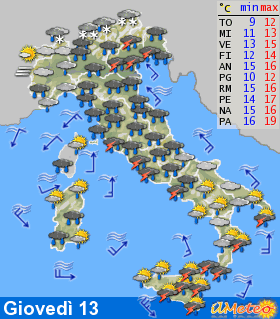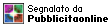Danno esistenziale e giudice amministrativo
Publicato da ADMIN su 18/6/2007 (507 Letto)
Danno esistenziale e giudice amministrativo
di Paolina Menga
I. Il danno esistenziale come autonomo titolo di pregiudizio. II. Il danno esistenziale nel giudizio amministrativo. III. La prova del danno esistenziale.
I. Il danno esistenziale come autonomo titolo di pregiudizio.
Negli ultimi decenni si è registrata una sempre maggiore attenzione verso i problemi della tutela risarcitoria della persona e l’elemento più significativo è costituito dalla ritrovata centralità dell’individuo nella visione dell’ordinamento giuridico. Come affermato, tra l’altro, dall’autorevole amministrativista Alberto Romano, già nel 1998, << è indubbio che il nostro diritto amministrativo si va evolvendo nel senso di dare maggiore rilievo agli interessi individuali, nei confronti di quelli pubblici che vi si contrappongono: non solo per sollecitazioni comunitarie, ma anche per spinte endogene>>. Pertanto, ad una crescita sociale verso le problematiche della tutela dell’uomo, si è accompagnata una rinnovata spinta giurisprudenziale e dottrinale, tesa a riconoscere sempre più, come valori fondamentali, aspetti del quotidiano vivere ed agire1. Significative sono risultate in tale ambito, inoltre, alcune pronunce, quali la storica decisione della Consulta nel 1986 in materia di danno biologico2 e la sentenza n. 500 del 1999 delle S.U. della Cassazione, con la quale è stata riconosciuta la risarcibilità degli interessi legittimi3. Nell’ultimo lustro la giurisprudenza si è poi incentrata su nuove figure di danno alla persona e, dopo aver enunciato i principi di cui alle sentenze della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003 4, ha individuato una terza voce di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente garantiti e risarcibili a prescindere dalla configurazione di un reato5. Tale voce di danno viene spesso definita in dottrina ed in giurisprudenza come danno c.d. esistenziale e si aggiunge alle altre due voci di danno, già ampiamente riconosciute6. Questa categoria di danno trova la propria fonte di tutela costituzionale nell’art. 2 della Costituzione, norma che tutela i diritti inviolabili dell’uomo sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. A seguito, poi, della interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., non essendo più necessaria la prova di un fatto reato, tale danno può essere liquidato, sempre che sussista il fatto illecito, anche in caso di responsabilità presunta o oggettiva. La querelle sulla autonoma configurabilità del danno esistenziale sembra essersi, comunque, ormai risolta con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 24 marzo 2006, n. 6572 7. Si rileva che la pronuncia delle Sezioni Unite ha ad oggetto una vicenda di danno da dequalificazione professionale del lavoratore, definito come <>. Emerge, pertanto, una figura di danno alla salute in senso lato che, dovendo- diversamente dal danno morale soggettivo- obiettivarsi, a differenza del danno biologico, rimane integrata a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale. Così, come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento8. Con la sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006 9, anche la III Sezione della Suprema Corte, recependo l’insegnamento delle Sezioni Unite, ha ribadito la piena autonomia del danno esistenziale. Quest’ultima decisione è stata già, a sua volta, recentemente confermata da altre due pronunce10, sempre della Corte Suprema. Cosicché, lo schema del danno risarcibile può essere riassunto in una prima distinzione bipolare fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ed in una ulteriore distinzione tripolare del danno non patrimoniale in danno morale soggettivo, danno biologico e c.d. danno esistenziale11.
Alla luce di quanto sopra, la varietà del panorama giuridico in materia risarcitoria richiede una certa sensibilità dell’interprete, in primis da parte dei giudici, che nel giudicare devono tener conto dei fatti e non dei nomi che si danno ai fatti, poiché la domanda di “risarcimento dei danni non patrimoniali” o di “risarcimento dei danni morali” comprende tutti i profili di danno non patrimoniali risarcibili; ciò che rileva non è che essi individuino o separino accuratamente i singoli profili di danno non patrimoniale, ma che nella liquidazione del danno non patrimoniale tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto dandone debita illustrazione nella motivazione delle loro sentenze12.
Non può, infine, essere accettata una interpretazione del concetto di “interesse garantito dalla costituzione” per il quale è tale qualunque posizione soggettiva che si possa ricondurre ad un qualsiasi precetto costituzionale, perché ciò equivarrebbe a risarcire il danno non patrimoniale sempre, in aperto contrasto all’art. 2059 c.c.. Non risarcire un danno quando la legge imponga di farlo è una ingiustizia, ma altrettanto lo è risarcire un danno quando non è previsto13. A tal proposito, parte della dottrina ritiene che sia opportuno porre un limite all’eccessiva dilatazione del danno esistenziale e, in particolare, che si debba escluderne il riconoscimento nei casi di pregiudizi di tipo bagatellare, sorti soprattutto negli ultimi anni, e che vanno, per citarne alcuni, dal “ballo di nozze intristito da rottura del tacco” “all’errato taglio di capelli che ha pregiudicato la cerimonia nuziale”, “dallo stress da disservizio postale” “alla mancata possibilità di assistere alle partite di calcio per smarrimento dell’abbonamento”14. E’ doveroso aggiungere che anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - la quale ha più volte riconosciuto la risarcibilità assoluta e senza limitazioni del danno in questione - ha influenzato i nostri giudici nazionali15, i quali devono non solo confrontarsi ma anche, in un certo senso, conformarsi alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo16. Al riguardo, si segnala la posizione assunta dalla Corte di Strasburgo in merito al risarcimento iure successionis dei danni non patrimoniali: diversamente dall’impostazione seguita dalla Cassazione17 in relazione alla risarcibilità del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico), la Corte europea ha riconosciuto il danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di morte istantanea.
II. Il danno esistenziale nel giudizio amministrativo.
Con la sentenza n. 1096 del 16 marzo 2005 anche la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto la figura del danno esistenziale18. In tale fattispecie, Palazzo Spada ha reputato sussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dall’omessa attribuzione della supplenza annuale a soggetto in condizione di minorazione fisica (ai sensi della legge n. 482 del 1968). In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2059 c.c. si risolve << non solo nella lesione, in assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale come diritto soggettivo, interesse legittimo o persino interesse adespota; ma anche, per quanto predicato dagli arresti citati dalla Cassazione in ordine all’art. 2059 c.c., nell’incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione, sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 Costituzione e, più in generale, dei principi fondamentali e nella parte I della Carta costituzionale (uguaglianza, libertà variamente tipizzate, famiglia, salute, studio,ecc.)19>>.
La giurisprudenza amministrativa, sebbene abbia a volte tacitamente riconosciuto il danno esistenziale20, lo ha menzionato espressamente solo in alcune recenti pronunce, tra cui, T.A.R. Bari 25 luglio 2003, n. 3000 21.
Il caso riguardava un provvedimento di fermo amministrativo di autovettura da parte di concessionario della riscossione, dichiarato illegittimo per difetto di motivazione del giudice amministrativo. Al riguardo, il Collegio rilevava che al fermo amministrativo, di cui all’art. 86, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, corrisponde << l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche graduarla nel suo oggetto>>. Inoltre, il giudice amministrativo ha affermato che:<< non può dubitarsi, in linea generale, che anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e, quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale>>.
Nell’ambito dell’attività svolta dalla P.A. il danno in argomento, si distingue in danno esistenziale provvedimentale (ove consegua ad un provvedimento illegittimo) e danno esistenziale comportamentale (qualora derivi da un’attività materiale e non sia legato alla attività funzionale autoritativa della Amministrazione). Con riferimento alla prima ipotesi, si segnala T.A.R. Napoli, sez. IV, 2 novembre 2005, n. 183222, che ha riguardato un caso di danno esistenziale provvedimentale (più precisamente un provvedimento di revoca del decreto di approvazione a nomina di guardia giurata, affetto da illegittimità, che ha determinato la sospensione dal lavoro): la guardia giurata ricorreva al T.A.R. Campania per chiedere il risarcimento del danno subito, essendo rimasto privo di reddito fino alla riassunzione in servizio, avendo subito un danno all’immagine conseguente alla illegittima sospensione ed avendo subito prostrazione e sofferenza psicologica che ne hanno determinato una generale depressione. Al riguardo, sul danno all’immagine lamentato, il Collegio, pur riconoscendolo, non lo ha ritenuto provato dal ricorrente. Secondo i giudici campani, questo tipo di danno deve essere provato, non esistendo in re ipsa in ogni ipotesi di illegittima sospensione dal servizio e deve essere puntualmente dedotto e dimostrato. Per quanto concerne l’altra ipotesi di danno esistenziale comportamentale, si segnala T.A.R. Torino, 27 febbraio 2004, n. 335, in merito al caso di un infermiere di sala operatoria, il quale in conseguenza della prestazione lavorativa svolta presso un ospedale, era risultato affetto da azospermia e da un disturbo congiuntivale corneale (a causa della non occasionale esposizione dell’interessato all’ossido di etilene). L’Amministrazione, incurante di una circolare del Ministero della Sanità- che limitava l’utilizzo di tale sostanza in considerazione della sua nocività- assumeva un atteggiamento omissivo nel limitare le possibilità di contatto degli addetti alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Il T.A.R. piemontese ha, pertanto, ritenuto che <>. L’Organo giudicante ha condannato, pertanto, l’Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale in via equitativa, tenendo conto anche dell’età del soggetto e delle sue condizioni personali. Da ultimo, si rammenta anche Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2006, n. 125 23, che ha riguardato un danno da ritardato pensionamento (caso diametralmente opposto rispetto alla questione esaminata precedentemente con la sentenza n. 1095 del 2005 del Consiglio di Stato) :<< Il Collegio reputa in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’appellante. Nella fattispecie che ci occupa è evidente la violazione di una posizione tutelata dall’ordinamento (che l’illecita condotta dell’amministrazione ha leso, ostacolando le attività realizzatrici della persona umana libera dall’impegno e dal logorio dell’attività lavorativa). Tanto detto sulla ricorrenza del danno ingiusto sub specie eventi, sul piano della prova, è jus receptum l’affermazione secondo la quale l’immaterialità dei pregiudizi in questione (lesione di valori inerenti alla persona) rende ammissibile il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valuzioni prognostiche anche basate su fatti notori o massime di comune esperienza. Nel caso in esame, il fatto della (forzata) protrazione dell’attività lavorativa consente di risalire al fatto ulteriore del peggioramento della qualità dell’esistenza. Aderendo alla concezione c.d. statica del danno esistenziale, esso emerge ipso iure, dalla prova del fatto antigiuridico (anche in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito) che reca in sé l’accertamento del danno ingiusto>>. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato, contrariamente all’orientamento dominante, ha accolto la concezione, ormai minoritaria, del danno esistenziale di tipo “eventistico”: l’evento lesivo è costituito dall’indebita prosecuzione dell’attività lavorativa e non è richiesta alcuna prova circa l’ostacolo allo svolgimento in concreto di una presunta attività degna di essere tutelata sotto il riparo del danno esistenziale24.
III. La prova del danno esistenziale.
La prova del danno esistenziale costituisce indubbiamente il più importante aspetto processuale: essa interessa sia il danno evento che ha provocato la lesione sia le conseguenze esistenziali che effettivamente ne sono derivate. “La qualificabilità di una conseguenza lesiva in termini di danno esistenziale, peraltro, consente una verifica in termini maggiormente obiettivi delle effettive conseguenze subite alle attività realizzatrici della persona. Il danno esistenziale attiene, infatti, ad un non fare (o ad un non fare più nello stesso modo o, ancora, ad un fare necessitato dall’evento), e come tale è agevolmente riscontrabile in base ad elementi esterni ed obiettivi”25. Ed è proprio su questo aspetto che sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata sentenza n. 6572 del 2006 26, affrontando la questione se il diritto del lavoratore al risarcimento del danno di natura esistenziale consegua in re ipsa al demansionamento o, al contrario, debba essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c. 27. Orbene, il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento va provato dal lavoratore, il quale è tenuto altresì a dimostrare, ai sensi dell’art. 1223 c.c., l’esistenza di un nesso di causalità fra l’inadempimento ed il danno e a precisare quale forma di danno da dequalificazione ritenga di aver subito, presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del pregiudizio ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 1226 c.c. 28.
<>. Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, in merito alla valorizzazione delle presunzioni, si colloca anche la già citata pronuncia della Cassazione n. 13546 del 2006: è stato ribadito che la prova del danno esistenziale da uccisione di stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni, le quali al riguardo assumono <>.
La presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l’onere della prova contraria (così, Cass. 27 novembre 1999, n. 13291). Pertanto, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Necessitando il danno in parola di una specifica dimostrazione (seppure con ricorso ad indici di tipo presuntivo), ben può comprendersi, a questo punto, la diversità di tutela del soggetto leso a seconda della giurisdizione adita. Anche se la legge n. 205 del 2000 (art. 7) ha previsto il potere del giudice amministrativo di disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile ed alla consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso espressamente l’interrogatorio formale ed il giuramento (prove c.d. legali), la cui efficacia è direttamente stabilita dalla legge e come tali incompatibili con il principio del libero convincimento del giudice che caratterizza il processo amministrativo di carattere impugnatorio31. Laddove risulta difficile dimostrare il danno esistenziale, si preferisce ricorrere alla “teoria eventista” e forse per questo motivo i giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 125 del 2006 hanno riconosciuto il danno esistenziale ipso iure, rilevando che <>. In materia di danno esistenziale risulta, così, evidente la differente struttura del processo amministrativo rispetto al processo civile sul piano probatorio. Il pieno riconoscimento del danno esistenziale da parte dei giudici amministrativi stenta, pertanto, ancora ad affermarsi a causa delle difficoltà di accertamento e di quantificazione32 del pregiudizio in questione, indipendentemente dal sindacato della illegittimità del provvedimento, che trova sicuramente in tale sede la sua naturale giurisdizione.
___________________
1 Così, LIBERATI A., in Danno esistenziale e Pubblica Amministrazione, UTET, Torino, 2005, 2.
2 V., Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, che ha collocato il danno biologico nell’ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., ravvisandone il fondamento nell’ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità biopsichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto alla salute contemplato dall’art. 32 della Costituzione) ai limiti posti dall’art. 2059 c.c. A questa pronuncia è seguita Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell’ambito dell’art. 2059 c.c., disponendo che << è sempre necessaria la prova che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato>>.
3 Secondo le Sezioni Unite, il risarcimento sarà possibile <>. Secondo COSTANZO, in La nuova disciplina del danno non patrimoniale, a cura di Dal Lago e Bordon, Giuffrè, 2005, 511-512, “La soluzione del conflitto tra interesse del privato e interesse perseguito dalla P.A. non è data dalla diversità dei contrapposti interessi. L’interesse pubblico non deve avere prevalenza in ogni caso. Si tratterà piuttosto di fare un’analisi in concreto e verificare se l’azione amministrativa sia conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione, oppure sia contraria a tali principi, e in questa seconda ipotesi se sia connotata, oltre che da illegittimità, anche dal dolo o dalla colpa. La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per attivare la tutela ex art. 2043 c.c.” .
4 V., Cass., III sez.civ., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, in Foro it., 2003, I, 2272, che hanno costituito le pietre miliari del percorso di modernizzazione della disciplina del danno non patrimoniale, reinterpretando l’art. 2059 c.c. In dottrina, cfr., per tutti, CENDON, Esistere o non esistere, in Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali, Padova, 2001, I, 2 e ss.
5 V., a tal proposito, Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Foro it, 2003, I, 2201, con nota di NAVARETTA, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c.
6 Il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima ed il danno biologico, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.).
7 Contra, v., PONZANELLI, in Danno e Responsabilità, n. 8-9, 2006, 849-850, il quale manifesta più di una perplessità: a) sulla qualificazione come danno esistenziale del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti ed interessi inerenti alla persona protetti a livello costituzionale; b) sui profili distintivi tra questa figura di danno e gli altri pregiudizi non patrimoniali; c) sulla legittimità per il danneggiato, sia primario sia secondario, di chiedere la riparazione di tutte e tre le figure di pregiudizi non patrimoniali. << Il vocabolo “esistenziale”- termine poco giuridico e preso a prestito dalla filosofia- è, infatti, espressione troppo generica e, soprattutto, è anfibologicamente pronto a salire dal nesso con la categoria dei rimedi, ove trova la sua istituzionale collocazione, per diventare esso stesso un jus, quasi che la presenza di un tale danno esistenziale, nella valutazione della vittima, diventasse la spia della violazione di un diritto inviolabile. Dello stesso avviso è anche VETTORI, nella relazione di apertura del Convegno di studi “Antiche e nuove prospettive di tutela nell’ambito della responsabilità civile, tenutosi a Firenze nei giorni 9-10 febbraio 2007, il quale definisce tale termine inconsistente e teme che la pretesa ad un’alta qualità della vita si possa trasformare in un diritto.
8 V., al riguardo, Cass., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 9009, in Danno e Resp., 2001, 1207, secondo la quale “Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il c.d. danno-evento (cioè il pregiudizio del diritto fondamentale), si colloca la valutazione del c.d. danno-conseguenza, cioè dell’entità del sacrificio sofferto, ai fini di una liquidazione naturaliter equitativa”.
9 In tale fattispecie, nell’affermare essere indiscutibile che la morte di un parente stretto menoma la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull’equilibrio e armonia del nucleo familiare e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo familiare pacificamente convivente e unito anche nell’attività lavorativa, la Corte Suprema ha ritenuto presuntivamente provato il danno esistenziale.
10 Si vedano, Cass, sez. II, 6 febbraio 2007, n. 2546, e Cass., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311, in Foro it, Anticipazioni e novità n. 2, 2007.
11 Contra,v., ZIVIZ, in La nuova era del danno non patrimoniale, www.Neldiritto.it, 2007.
12 Così, LIMA, in Il danno esistenziale, 2007.
13 Così, sempre LIMA, in op.cit. Dello stesso avviso è RESCIGNO, nella relazione tenuta al convegno di Firenze sopra citato, il quale nutre riserve per l’attuale evoluzione della responsabilità civile a causa di rivendicazioni arbitrarie, in un sistema in cui oggi più dell’avere della persona conta l’essere con i suoi desideri da soddisfare.
14 Si vedano, Giudice di Pace di Palermo, 17 maggio 2004, Giudice di Pace di Catania 25 aprile 1999, Giudice di Pace di Avellino 6 maggio 2001, Cass. 27 luglio 2006, n. 17144.
15 In tal senso, v., Trib. Biella 1 giugno 2005, il quale ha sostenuto che l’obbligo di conformarsi non può valere esclusivamente per l’interpretazione della c.d. legge Pinto (n. 89 del 24 marzo 2001), bensì può riferirsi all’applicazione di qualsiasi altra norma di diritto interno, ove siano in gioco diritti o libertà previste dalla CEDU. In dottrina, v., BONA, Il danno alla persona nel codice delle Assicurazioni e nel processo civile, IPSOA, 2006.
16 V., Cass. S.U. 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341, che, intervenendo sui criteri di quantificazione del danno non patrimoniale da mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avevano affermato tale obbligo di conformazione
17 Cass. 26 ottobre 2004, n. 20746, in Resp.civ., 2005, 71, nega l’esistenza del danno biologico iure hereditatis, non prendendo in esame le cognizioni scientifiche che hanno accertato che la morte conseguente ad una lesione traumatica non è mai immediata. Per un ulteriore approfondimento, v., CHINDEMI, in Danno esistenziale e danno tanatologico, www.Lapraticaforense.it, 2007. Non può sottacersi, inoltre, che in ambito di responsabilità civile automobilistica, stante l’entrata in vigore della nuova definizione di danno biologico, prevista dagli artt. 138 e 139 del d. lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni), che ingloba il danno esistenziale all’interno del danno biologico c.d. statico, restano aperti nel nostro ordinamento i problemi di come liquidare il danno esistenziale in modo uniforme nei diversi fori e della stessa legittimità di tale voce (che il codice sembra ignorare). Anche RESCIGNO, in op.cit., critica i codici speciali, frutto di pressioni corporative e che mancano di chiarezza, semplicità e coerenza. Al riguardo, v., anche RODOLFI, in Maggiore personalizzazione del danno, Guida al diritto, n. 8, 2006, 15.
18 VIOLA, in Il danno esistenziale nella responsabilità civile della Pubblica Amministrazione,Piacenza, 2003, ritiene che tutte le ipotesi di danno esistenziale cagionato dalla P.A. al privato nell’esercizio di poteri autoritativi, andrebbero risarcite facendo riferimento all’art. 97 della Cost., che, prevedendo un dovere di buon andamento e imparzialità, imporrebbe alla P.A. medesima di non ledere i valori costituzionalmente protetti di chi è coinvolto nel procedimento.
19 Nella specie, l’appellante, privata di un incarico lavorativo spettantele quale titolare di una riserva per le sue condizioni di minorazione fisica, ha patito un vulnus dato dalle lesioni di situazioni di rilievo costituzionale: per i soggetti appartenenti a categorie protette l’accesso al lavoro costituisce essenziale strumento di affermazione della piena dignità della persona e dimostrazione del loro pieno inserimento sociale.
20 Così, Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2003, n. 5820: il caso riguardava una condanna dell’Amministrazione per mancata ottemperanza al giudicato a seguito della quale, per l’intervento di modifiche normative, il privato aveva visto definitivamente svanire la possibilità di riavere indietro la propria abitazione, la quale era stata oggetto di esproprio accertato come illegittimo.
21 T.A.R. Bari, sez. I, 25 luglio 2003, n. 3000, in Consiglio di Stato, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, 2003, 355, con nota di VIOLA.
22 In Danno e Resp., n.1, 2006, 105. Al riguardo, si veda, anche T.A.R. Catania, 19 giugno 2001, n. 1223, che ha condannato l’Amministrazione resistente a risarcire il pregiudizio per l’illegittima revoca del porto d’armi ravvisando un’ingiustizia del danno in quanto incidente su di una situazione tutelata dall’ordinamento, avente consistenza di interesse legittimo ed in quanto il ricorrente è stato non soltanto deupaperato nella sfera patrimoniale, in termini di danno emergente, ma altresì privato di benefici che nella nuova concezione di danno risarcibile vedono presi in considerazione, a seconda delle diverse impostazioni in termini di danno esistenziale, come danno che almeno potenzialmente ostacola le attività realizzatrici della persona, ai sensi dell’art. 2043 c.c., correlato all’art. 2 Cost.
23 Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125.
24 In dottrina, v., in tal senso, VIOLA, op.cit.,40 “Ed in effetti, in un sistema amministrativo fortemente normativizzato e che vede al vertice una Costituzione che, sia pure con una forte eccessiva sinteticità, prevede disposizioni (l’art.97, I comma, ma anche tutte le altre previsioni destinate alla disciplina dell’attività amministrativa) specificamente destinate a regolare aspetti specifici dell’attività amministrativa, la via costituzional-eventistica viene ad integrare decisive chances di tutela che non possono certamente essere trascurate.
25 Così, LIBERATI, op.cit., 204.
26 Dall’inadempimento datoriale, di natura contrattuale ex art. 2103 c.c (divieto di dequalificazione) e art. 2078 c.c. (obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore), non deriva automaticamente l’esistenza del danno non patrimoniale. L’inadempimento è, infatti, già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.
27 La condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale è prevista espressamente dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, il lavoratore può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 2729, I comma, del cod.civ.
28 Secondo le S.U. il lavoratore ha l’onere esclusivo di provare che la dequalificazione ha prodotto una perdita rappresentata da una diminuzione o privazione di un valore personale alla quale il risarcimento del danno deve essere commisurato. In dottrina, v., D’ADDA, Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio, nota a Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in Foro it., 2001, I, 203, il quale, sebbene contrario ad un riconoscimento del danno esistenziale come categoria autonoma, sostiene che il pregiudizio esistenziale, per essere risarcito, deve essere in primo luogo provato.
29 Secondo Cass. 29 aprile 2004, n. 8271, in Riv.giur.lav., 2005, 276, il giudice può dedurre l’esistenza del danno da elementi di fatto, quali la durata del demansionamento.
30 Nel caso concreto, per la Corte il fatto-base è costituito dal rapporto di coniugio o di filiazione e dalla convivenza con il defunto da cui- secondo regole di comune esperienza ed un canone di ragionevole probabilità- discende la presunzione che la privazione del congiunto determini (pur temporaneamente) ripercussioni sulla sfera dell’individuo. In tal senso, v., anche Corte App. Milano 29 gennaio 2007, la quale afferma che nel codice civile sono previste forme di responsabilità oggettiva, ma non è previsto alcun danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente dalla sua prova, né alcuna presunzione di danno. Inoltre, nel caso in cui dall’indagine è risultato che il danno esistenziale si è sovrapposto ad una situazione di valenza esistenziale già compromessa, sarà risarcibile solamente il danno esistenziale c.d. differenziale.
31 Alla luce della recente riforma, l’indiscriminata esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento non trova più la giustificazione per cui tale esclusione era stata in passato affermata. Infatti, nelle materie di giurisdizione esclusiva, quando viene dedotto in lite un rapporto giuridico paritetico, quindi di natura civilistica, non si vede la ragione per cui l’interrogatorio formale ed il giuramento debbano essere esclusi. Se in questi casi deve ritenersi operante il principio dell’onere della prova, tale esclusione parrebbe porsi in contrasto con il relativo regime probatorio e suscitare, addirittura, dubbi di legittimità costituzionale (Così, in Giustizia Ammnistrativa,a cura di SCOCA, Giappichelli, Torino, 2006, 317).
32 La liquidazione del danno è strettamente legata all’argomento di prova da produrre in giudizio e, a seguito del carattere fortemente soggettivo della lesione, la modalità di liquidazione non può certo essere rappresentata da tabelle predeterminate, bensì dal criterio dell’equità (artt. 1226 e 2056 c.c.), ampiamente preferito dalla giurisprudenza. Per la determinazione del “quantum”, al fine di evitare possibili liquidazioni arbitrarie, si ritiene opportuno, tra l’altro, individuare parametri di valutazione omogenei, cercando di tener conto di: a) personalità del soggetto leso; b) interesse violato; c) attività (familiari, sociali, lavorative) precedentemente svolte e compromesse dal fatto illecito; d) durata effettiva della lesione. Parte della dottrina si è di recente adoperata nel fornire meccanismi alternativi al metodo equitativo, come il criterio dell’equazione di LIBERATI (in La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004) o l’equità calibrata di CASSANO, in Provare, risarcire e liquidare il danno esistenziale, Milano, 2005). Si veda, da ultimo, per un ulteriore approfondimento, TRAMONTANO, in Il danno esistenziale ed il suo risarcimento, Piacenza, 2006.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=37309
di Paolina Menga
I. Il danno esistenziale come autonomo titolo di pregiudizio. II. Il danno esistenziale nel giudizio amministrativo. III. La prova del danno esistenziale.
I. Il danno esistenziale come autonomo titolo di pregiudizio.
Negli ultimi decenni si è registrata una sempre maggiore attenzione verso i problemi della tutela risarcitoria della persona e l’elemento più significativo è costituito dalla ritrovata centralità dell’individuo nella visione dell’ordinamento giuridico. Come affermato, tra l’altro, dall’autorevole amministrativista Alberto Romano, già nel 1998, << è indubbio che il nostro diritto amministrativo si va evolvendo nel senso di dare maggiore rilievo agli interessi individuali, nei confronti di quelli pubblici che vi si contrappongono: non solo per sollecitazioni comunitarie, ma anche per spinte endogene>>. Pertanto, ad una crescita sociale verso le problematiche della tutela dell’uomo, si è accompagnata una rinnovata spinta giurisprudenziale e dottrinale, tesa a riconoscere sempre più, come valori fondamentali, aspetti del quotidiano vivere ed agire1. Significative sono risultate in tale ambito, inoltre, alcune pronunce, quali la storica decisione della Consulta nel 1986 in materia di danno biologico2 e la sentenza n. 500 del 1999 delle S.U. della Cassazione, con la quale è stata riconosciuta la risarcibilità degli interessi legittimi3. Nell’ultimo lustro la giurisprudenza si è poi incentrata su nuove figure di danno alla persona e, dopo aver enunciato i principi di cui alle sentenze della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003 4, ha individuato una terza voce di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente garantiti e risarcibili a prescindere dalla configurazione di un reato5. Tale voce di danno viene spesso definita in dottrina ed in giurisprudenza come danno c.d. esistenziale e si aggiunge alle altre due voci di danno, già ampiamente riconosciute6. Questa categoria di danno trova la propria fonte di tutela costituzionale nell’art. 2 della Costituzione, norma che tutela i diritti inviolabili dell’uomo sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. A seguito, poi, della interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., non essendo più necessaria la prova di un fatto reato, tale danno può essere liquidato, sempre che sussista il fatto illecito, anche in caso di responsabilità presunta o oggettiva. La querelle sulla autonoma configurabilità del danno esistenziale sembra essersi, comunque, ormai risolta con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 24 marzo 2006, n. 6572 7. Si rileva che la pronuncia delle Sezioni Unite ha ad oggetto una vicenda di danno da dequalificazione professionale del lavoratore, definito come <
Alla luce di quanto sopra, la varietà del panorama giuridico in materia risarcitoria richiede una certa sensibilità dell’interprete, in primis da parte dei giudici, che nel giudicare devono tener conto dei fatti e non dei nomi che si danno ai fatti, poiché la domanda di “risarcimento dei danni non patrimoniali” o di “risarcimento dei danni morali” comprende tutti i profili di danno non patrimoniali risarcibili; ciò che rileva non è che essi individuino o separino accuratamente i singoli profili di danno non patrimoniale, ma che nella liquidazione del danno non patrimoniale tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto dandone debita illustrazione nella motivazione delle loro sentenze12.
Non può, infine, essere accettata una interpretazione del concetto di “interesse garantito dalla costituzione” per il quale è tale qualunque posizione soggettiva che si possa ricondurre ad un qualsiasi precetto costituzionale, perché ciò equivarrebbe a risarcire il danno non patrimoniale sempre, in aperto contrasto all’art. 2059 c.c.. Non risarcire un danno quando la legge imponga di farlo è una ingiustizia, ma altrettanto lo è risarcire un danno quando non è previsto13. A tal proposito, parte della dottrina ritiene che sia opportuno porre un limite all’eccessiva dilatazione del danno esistenziale e, in particolare, che si debba escluderne il riconoscimento nei casi di pregiudizi di tipo bagatellare, sorti soprattutto negli ultimi anni, e che vanno, per citarne alcuni, dal “ballo di nozze intristito da rottura del tacco” “all’errato taglio di capelli che ha pregiudicato la cerimonia nuziale”, “dallo stress da disservizio postale” “alla mancata possibilità di assistere alle partite di calcio per smarrimento dell’abbonamento”14. E’ doveroso aggiungere che anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - la quale ha più volte riconosciuto la risarcibilità assoluta e senza limitazioni del danno in questione - ha influenzato i nostri giudici nazionali15, i quali devono non solo confrontarsi ma anche, in un certo senso, conformarsi alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo16. Al riguardo, si segnala la posizione assunta dalla Corte di Strasburgo in merito al risarcimento iure successionis dei danni non patrimoniali: diversamente dall’impostazione seguita dalla Cassazione17 in relazione alla risarcibilità del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico), la Corte europea ha riconosciuto il danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di morte istantanea.
II. Il danno esistenziale nel giudizio amministrativo.
Con la sentenza n. 1096 del 16 marzo 2005 anche la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto la figura del danno esistenziale18. In tale fattispecie, Palazzo Spada ha reputato sussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dall’omessa attribuzione della supplenza annuale a soggetto in condizione di minorazione fisica (ai sensi della legge n. 482 del 1968). In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2059 c.c. si risolve << non solo nella lesione, in assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale come diritto soggettivo, interesse legittimo o persino interesse adespota; ma anche, per quanto predicato dagli arresti citati dalla Cassazione in ordine all’art. 2059 c.c., nell’incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione, sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 Costituzione e, più in generale, dei principi fondamentali e nella parte I della Carta costituzionale (uguaglianza, libertà variamente tipizzate, famiglia, salute, studio,ecc.)19>>.
La giurisprudenza amministrativa, sebbene abbia a volte tacitamente riconosciuto il danno esistenziale20, lo ha menzionato espressamente solo in alcune recenti pronunce, tra cui, T.A.R. Bari 25 luglio 2003, n. 3000 21.
Il caso riguardava un provvedimento di fermo amministrativo di autovettura da parte di concessionario della riscossione, dichiarato illegittimo per difetto di motivazione del giudice amministrativo. Al riguardo, il Collegio rilevava che al fermo amministrativo, di cui all’art. 86, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, corrisponde << l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche graduarla nel suo oggetto>>. Inoltre, il giudice amministrativo ha affermato che:<< non può dubitarsi, in linea generale, che anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e, quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale>>.
Nell’ambito dell’attività svolta dalla P.A. il danno in argomento, si distingue in danno esistenziale provvedimentale (ove consegua ad un provvedimento illegittimo) e danno esistenziale comportamentale (qualora derivi da un’attività materiale e non sia legato alla attività funzionale autoritativa della Amministrazione). Con riferimento alla prima ipotesi, si segnala T.A.R. Napoli, sez. IV, 2 novembre 2005, n. 183222, che ha riguardato un caso di danno esistenziale provvedimentale (più precisamente un provvedimento di revoca del decreto di approvazione a nomina di guardia giurata, affetto da illegittimità, che ha determinato la sospensione dal lavoro): la guardia giurata ricorreva al T.A.R. Campania per chiedere il risarcimento del danno subito, essendo rimasto privo di reddito fino alla riassunzione in servizio, avendo subito un danno all’immagine conseguente alla illegittima sospensione ed avendo subito prostrazione e sofferenza psicologica che ne hanno determinato una generale depressione. Al riguardo, sul danno all’immagine lamentato, il Collegio, pur riconoscendolo, non lo ha ritenuto provato dal ricorrente. Secondo i giudici campani, questo tipo di danno deve essere provato, non esistendo in re ipsa in ogni ipotesi di illegittima sospensione dal servizio e deve essere puntualmente dedotto e dimostrato. Per quanto concerne l’altra ipotesi di danno esistenziale comportamentale, si segnala T.A.R. Torino, 27 febbraio 2004, n. 335, in merito al caso di un infermiere di sala operatoria, il quale in conseguenza della prestazione lavorativa svolta presso un ospedale, era risultato affetto da azospermia e da un disturbo congiuntivale corneale (a causa della non occasionale esposizione dell’interessato all’ossido di etilene). L’Amministrazione, incurante di una circolare del Ministero della Sanità- che limitava l’utilizzo di tale sostanza in considerazione della sua nocività- assumeva un atteggiamento omissivo nel limitare le possibilità di contatto degli addetti alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Il T.A.R. piemontese ha, pertanto, ritenuto che <
III. La prova del danno esistenziale.
La prova del danno esistenziale costituisce indubbiamente il più importante aspetto processuale: essa interessa sia il danno evento che ha provocato la lesione sia le conseguenze esistenziali che effettivamente ne sono derivate. “La qualificabilità di una conseguenza lesiva in termini di danno esistenziale, peraltro, consente una verifica in termini maggiormente obiettivi delle effettive conseguenze subite alle attività realizzatrici della persona. Il danno esistenziale attiene, infatti, ad un non fare (o ad un non fare più nello stesso modo o, ancora, ad un fare necessitato dall’evento), e come tale è agevolmente riscontrabile in base ad elementi esterni ed obiettivi”25. Ed è proprio su questo aspetto che sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata sentenza n. 6572 del 2006 26, affrontando la questione se il diritto del lavoratore al risarcimento del danno di natura esistenziale consegua in re ipsa al demansionamento o, al contrario, debba essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c. 27. Orbene, il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento va provato dal lavoratore, il quale è tenuto altresì a dimostrare, ai sensi dell’art. 1223 c.c., l’esistenza di un nesso di causalità fra l’inadempimento ed il danno e a precisare quale forma di danno da dequalificazione ritenga di aver subito, presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del pregiudizio ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 1226 c.c. 28.
<
La presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l’onere della prova contraria (così, Cass. 27 novembre 1999, n. 13291). Pertanto, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Necessitando il danno in parola di una specifica dimostrazione (seppure con ricorso ad indici di tipo presuntivo), ben può comprendersi, a questo punto, la diversità di tutela del soggetto leso a seconda della giurisdizione adita. Anche se la legge n. 205 del 2000 (art. 7) ha previsto il potere del giudice amministrativo di disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile ed alla consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso espressamente l’interrogatorio formale ed il giuramento (prove c.d. legali), la cui efficacia è direttamente stabilita dalla legge e come tali incompatibili con il principio del libero convincimento del giudice che caratterizza il processo amministrativo di carattere impugnatorio31. Laddove risulta difficile dimostrare il danno esistenziale, si preferisce ricorrere alla “teoria eventista” e forse per questo motivo i giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 125 del 2006 hanno riconosciuto il danno esistenziale ipso iure, rilevando che <
___________________
1 Così, LIBERATI A., in Danno esistenziale e Pubblica Amministrazione, UTET, Torino, 2005, 2.
2 V., Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, che ha collocato il danno biologico nell’ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., ravvisandone il fondamento nell’ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità biopsichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto alla salute contemplato dall’art. 32 della Costituzione) ai limiti posti dall’art. 2059 c.c. A questa pronuncia è seguita Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell’ambito dell’art. 2059 c.c., disponendo che << è sempre necessaria la prova che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato>>.
3 Secondo le Sezioni Unite, il risarcimento sarà possibile <
4 V., Cass., III sez.civ., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, in Foro it., 2003, I, 2272, che hanno costituito le pietre miliari del percorso di modernizzazione della disciplina del danno non patrimoniale, reinterpretando l’art. 2059 c.c. In dottrina, cfr., per tutti, CENDON, Esistere o non esistere, in Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali, Padova, 2001, I, 2 e ss.
5 V., a tal proposito, Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Foro it, 2003, I, 2201, con nota di NAVARETTA, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c.
6 Il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima ed il danno biologico, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.).
7 Contra, v., PONZANELLI, in Danno e Responsabilità, n. 8-9, 2006, 849-850, il quale manifesta più di una perplessità: a) sulla qualificazione come danno esistenziale del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti ed interessi inerenti alla persona protetti a livello costituzionale; b) sui profili distintivi tra questa figura di danno e gli altri pregiudizi non patrimoniali; c) sulla legittimità per il danneggiato, sia primario sia secondario, di chiedere la riparazione di tutte e tre le figure di pregiudizi non patrimoniali. << Il vocabolo “esistenziale”- termine poco giuridico e preso a prestito dalla filosofia- è, infatti, espressione troppo generica e, soprattutto, è anfibologicamente pronto a salire dal nesso con la categoria dei rimedi, ove trova la sua istituzionale collocazione, per diventare esso stesso un jus, quasi che la presenza di un tale danno esistenziale, nella valutazione della vittima, diventasse la spia della violazione di un diritto inviolabile. Dello stesso avviso è anche VETTORI, nella relazione di apertura del Convegno di studi “Antiche e nuove prospettive di tutela nell’ambito della responsabilità civile, tenutosi a Firenze nei giorni 9-10 febbraio 2007, il quale definisce tale termine inconsistente e teme che la pretesa ad un’alta qualità della vita si possa trasformare in un diritto.
8 V., al riguardo, Cass., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 9009, in Danno e Resp., 2001, 1207, secondo la quale “Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il c.d. danno-evento (cioè il pregiudizio del diritto fondamentale), si colloca la valutazione del c.d. danno-conseguenza, cioè dell’entità del sacrificio sofferto, ai fini di una liquidazione naturaliter equitativa”.
9 In tale fattispecie, nell’affermare essere indiscutibile che la morte di un parente stretto menoma la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull’equilibrio e armonia del nucleo familiare e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo familiare pacificamente convivente e unito anche nell’attività lavorativa, la Corte Suprema ha ritenuto presuntivamente provato il danno esistenziale.
10 Si vedano, Cass, sez. II, 6 febbraio 2007, n. 2546, e Cass., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311, in Foro it, Anticipazioni e novità n. 2, 2007.
11 Contra,v., ZIVIZ, in La nuova era del danno non patrimoniale, www.Neldiritto.it, 2007.
12 Così, LIMA, in Il danno esistenziale, 2007.
13 Così, sempre LIMA, in op.cit. Dello stesso avviso è RESCIGNO, nella relazione tenuta al convegno di Firenze sopra citato, il quale nutre riserve per l’attuale evoluzione della responsabilità civile a causa di rivendicazioni arbitrarie, in un sistema in cui oggi più dell’avere della persona conta l’essere con i suoi desideri da soddisfare.
14 Si vedano, Giudice di Pace di Palermo, 17 maggio 2004, Giudice di Pace di Catania 25 aprile 1999, Giudice di Pace di Avellino 6 maggio 2001, Cass. 27 luglio 2006, n. 17144.
15 In tal senso, v., Trib. Biella 1 giugno 2005, il quale ha sostenuto che l’obbligo di conformarsi non può valere esclusivamente per l’interpretazione della c.d. legge Pinto (n. 89 del 24 marzo 2001), bensì può riferirsi all’applicazione di qualsiasi altra norma di diritto interno, ove siano in gioco diritti o libertà previste dalla CEDU. In dottrina, v., BONA, Il danno alla persona nel codice delle Assicurazioni e nel processo civile, IPSOA, 2006.
16 V., Cass. S.U. 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341, che, intervenendo sui criteri di quantificazione del danno non patrimoniale da mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avevano affermato tale obbligo di conformazione
17 Cass. 26 ottobre 2004, n. 20746, in Resp.civ., 2005, 71, nega l’esistenza del danno biologico iure hereditatis, non prendendo in esame le cognizioni scientifiche che hanno accertato che la morte conseguente ad una lesione traumatica non è mai immediata. Per un ulteriore approfondimento, v., CHINDEMI, in Danno esistenziale e danno tanatologico, www.Lapraticaforense.it, 2007. Non può sottacersi, inoltre, che in ambito di responsabilità civile automobilistica, stante l’entrata in vigore della nuova definizione di danno biologico, prevista dagli artt. 138 e 139 del d. lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni), che ingloba il danno esistenziale all’interno del danno biologico c.d. statico, restano aperti nel nostro ordinamento i problemi di come liquidare il danno esistenziale in modo uniforme nei diversi fori e della stessa legittimità di tale voce (che il codice sembra ignorare). Anche RESCIGNO, in op.cit., critica i codici speciali, frutto di pressioni corporative e che mancano di chiarezza, semplicità e coerenza. Al riguardo, v., anche RODOLFI, in Maggiore personalizzazione del danno, Guida al diritto, n. 8, 2006, 15.
18 VIOLA, in Il danno esistenziale nella responsabilità civile della Pubblica Amministrazione,Piacenza, 2003, ritiene che tutte le ipotesi di danno esistenziale cagionato dalla P.A. al privato nell’esercizio di poteri autoritativi, andrebbero risarcite facendo riferimento all’art. 97 della Cost., che, prevedendo un dovere di buon andamento e imparzialità, imporrebbe alla P.A. medesima di non ledere i valori costituzionalmente protetti di chi è coinvolto nel procedimento.
19 Nella specie, l’appellante, privata di un incarico lavorativo spettantele quale titolare di una riserva per le sue condizioni di minorazione fisica, ha patito un vulnus dato dalle lesioni di situazioni di rilievo costituzionale: per i soggetti appartenenti a categorie protette l’accesso al lavoro costituisce essenziale strumento di affermazione della piena dignità della persona e dimostrazione del loro pieno inserimento sociale.
20 Così, Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2003, n. 5820: il caso riguardava una condanna dell’Amministrazione per mancata ottemperanza al giudicato a seguito della quale, per l’intervento di modifiche normative, il privato aveva visto definitivamente svanire la possibilità di riavere indietro la propria abitazione, la quale era stata oggetto di esproprio accertato come illegittimo.
21 T.A.R. Bari, sez. I, 25 luglio 2003, n. 3000, in Consiglio di Stato, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, 2003, 355, con nota di VIOLA.
22 In Danno e Resp., n.1, 2006, 105. Al riguardo, si veda, anche T.A.R. Catania, 19 giugno 2001, n. 1223, che ha condannato l’Amministrazione resistente a risarcire il pregiudizio per l’illegittima revoca del porto d’armi ravvisando un’ingiustizia del danno in quanto incidente su di una situazione tutelata dall’ordinamento, avente consistenza di interesse legittimo ed in quanto il ricorrente è stato non soltanto deupaperato nella sfera patrimoniale, in termini di danno emergente, ma altresì privato di benefici che nella nuova concezione di danno risarcibile vedono presi in considerazione, a seconda delle diverse impostazioni in termini di danno esistenziale, come danno che almeno potenzialmente ostacola le attività realizzatrici della persona, ai sensi dell’art. 2043 c.c., correlato all’art. 2 Cost.
23 Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125.
24 In dottrina, v., in tal senso, VIOLA, op.cit.,40 “Ed in effetti, in un sistema amministrativo fortemente normativizzato e che vede al vertice una Costituzione che, sia pure con una forte eccessiva sinteticità, prevede disposizioni (l’art.97, I comma, ma anche tutte le altre previsioni destinate alla disciplina dell’attività amministrativa) specificamente destinate a regolare aspetti specifici dell’attività amministrativa, la via costituzional-eventistica viene ad integrare decisive chances di tutela che non possono certamente essere trascurate.
25 Così, LIBERATI, op.cit., 204.
26 Dall’inadempimento datoriale, di natura contrattuale ex art. 2103 c.c (divieto di dequalificazione) e art. 2078 c.c. (obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore), non deriva automaticamente l’esistenza del danno non patrimoniale. L’inadempimento è, infatti, già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.
27 La condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale è prevista espressamente dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, il lavoratore può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’art. 2729, I comma, del cod.civ.
28 Secondo le S.U. il lavoratore ha l’onere esclusivo di provare che la dequalificazione ha prodotto una perdita rappresentata da una diminuzione o privazione di un valore personale alla quale il risarcimento del danno deve essere commisurato. In dottrina, v., D’ADDA, Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio, nota a Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in Foro it., 2001, I, 203, il quale, sebbene contrario ad un riconoscimento del danno esistenziale come categoria autonoma, sostiene che il pregiudizio esistenziale, per essere risarcito, deve essere in primo luogo provato.
29 Secondo Cass. 29 aprile 2004, n. 8271, in Riv.giur.lav., 2005, 276, il giudice può dedurre l’esistenza del danno da elementi di fatto, quali la durata del demansionamento.
30 Nel caso concreto, per la Corte il fatto-base è costituito dal rapporto di coniugio o di filiazione e dalla convivenza con il defunto da cui- secondo regole di comune esperienza ed un canone di ragionevole probabilità- discende la presunzione che la privazione del congiunto determini (pur temporaneamente) ripercussioni sulla sfera dell’individuo. In tal senso, v., anche Corte App. Milano 29 gennaio 2007, la quale afferma che nel codice civile sono previste forme di responsabilità oggettiva, ma non è previsto alcun danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente dalla sua prova, né alcuna presunzione di danno. Inoltre, nel caso in cui dall’indagine è risultato che il danno esistenziale si è sovrapposto ad una situazione di valenza esistenziale già compromessa, sarà risarcibile solamente il danno esistenziale c.d. differenziale.
31 Alla luce della recente riforma, l’indiscriminata esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento non trova più la giustificazione per cui tale esclusione era stata in passato affermata. Infatti, nelle materie di giurisdizione esclusiva, quando viene dedotto in lite un rapporto giuridico paritetico, quindi di natura civilistica, non si vede la ragione per cui l’interrogatorio formale ed il giuramento debbano essere esclusi. Se in questi casi deve ritenersi operante il principio dell’onere della prova, tale esclusione parrebbe porsi in contrasto con il relativo regime probatorio e suscitare, addirittura, dubbi di legittimità costituzionale (Così, in Giustizia Ammnistrativa,a cura di SCOCA, Giappichelli, Torino, 2006, 317).
32 La liquidazione del danno è strettamente legata all’argomento di prova da produrre in giudizio e, a seguito del carattere fortemente soggettivo della lesione, la modalità di liquidazione non può certo essere rappresentata da tabelle predeterminate, bensì dal criterio dell’equità (artt. 1226 e 2056 c.c.), ampiamente preferito dalla giurisprudenza. Per la determinazione del “quantum”, al fine di evitare possibili liquidazioni arbitrarie, si ritiene opportuno, tra l’altro, individuare parametri di valutazione omogenei, cercando di tener conto di: a) personalità del soggetto leso; b) interesse violato; c) attività (familiari, sociali, lavorative) precedentemente svolte e compromesse dal fatto illecito; d) durata effettiva della lesione. Parte della dottrina si è di recente adoperata nel fornire meccanismi alternativi al metodo equitativo, come il criterio dell’equazione di LIBERATI (in La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004) o l’equità calibrata di CASSANO, in Provare, risarcire e liquidare il danno esistenziale, Milano, 2005). Si veda, da ultimo, per un ulteriore approfondimento, TRAMONTANO, in Il danno esistenziale ed il suo risarcimento, Piacenza, 2006.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=37309
| Naviga negli articoli | |
 Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata
Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata
|
Cassazione: Sentenza violazione limiti massimi per il lavoro straordinario

|
|
I commenti sono proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.
|